![]() Francesco Russo - Direttore Spiralis Mirabilis, studioso, praticante e insegnante di arti marziali tradizionali cinesi
Francesco Russo - Direttore Spiralis Mirabilis, studioso, praticante e insegnante di arti marziali tradizionali cinesi
Pagina pubblicata in data
21 luglio 2025
Aggiornata al 22 luglio 2025

L’intervista con il maestro Paolo Spongia si è rivelata una lunga e piacevole conversazione con una persona che in Italia è divenuta un punto di riferimento per il Goju-Ryu Karate. Oggi è capo istruttore della sezione italiana della IOGKF (International Okinawan Goju-Ryu Karate Federation). Federazione che si pone lo scopo di preservare e diffondere l’autentico Karate di Okinawa.
Perché intervistare un maestro di una disciplina simbolo del Giappone per una rivista dedicata alle arti marziali tradizionali cinesi?
Il motivo è che il Karate praticato a Okinawa ha forti legami con le arti marziali tradizionali cinesi, in particolare con gli stili del sud. Il Goju-Ryu ha, infatti, profondi legami con gli stili insegnati nella provincia cinese del 福建 fújiàn.
Alcune fonti, non suffragate da documentazione storica ma solo da una tradizione orale, indicano che questo stile nasce dall’antico stile dello 鶴拳 hè quán e che abbia avuto origine nella città di 福州 fúzhōu. Ecco il motivo che mi ha portato a richiedere al maestro Spongia la disponibilità a essere intervistato.
Il maestro, inoltre, non è solo un punto di riferimento in Italia per il Goju-Ryu, ma è anche un monaco appartenente alla scuola sōtō-shū, una delle due maggiori scuole giapponesi del buddismo zen. Il Dojo che ha fondato a Roma, il Tora Kan Dojo, è sì un luogo dove si praticano le arti marziali ma è anche un luogo dove studiare e praticare il buddismo zen.
Una figura così peculiare e interessante non poteva "sfuggire" ai radar della nostra rivista.
Uno dei primi aspetti che ho affrontato con lui è stato il tema del "confronto".
Il maestro mi ha descritto come il ritorno a Okinawa si trasforma ogni volta per lui in un’occasione di confronto fra differenti scuole e maestri. Non solo. In passato a Okinawa si sono tenuti scambi e confronti anche con maestri e scuole del sud della Cina. Tanto che mi ha raccontato di un piccolo episodio avvenuto in occasione di uno dei primi scambi fra maestri cinesi e maestri di Okinawa. In quell’occasione i maestri cinesi si "commossero" nel vedere praticato il Goju-Ryu. Per loro fu come assistere a ciò che fu praticato in passato in Cina e di cui in parte si è persa la memoria.
La cultura di Okinawa a causa della sua posizione geografica presenta notevoli differenze rispetto alla cultura giapponese. Nasce dalla fusione di tradizioni locali e influenze cinesi. Questa mescolanza ha portato a una cultura distintiva che si differenzia significativamente dalla cultura e dalla tradizione del Giappone.
Una sottolineatura importante che il maestro Spongia ha fatto è stata sull’importanza da parte degli allievi e delle allieve del suo Dojo di partecipare ai "gasshuku", che offrono l’opportunità di osservare altri maestri, così da non avere come misura solo il proprio o la propria maestra. Ai "gasshuku" si ha la possibilità di essere stimolati da nuove chiavi di lettura per qualcosa che magari si è studiato nel proprio dojo.
Il corpo di ogni persona è diverso e l’interpretazione del movimento che nasce da un’esperienza che è individuale permette di cogliere anche nel gesto più semplice, nel solo suono con cui è emesso, qualcosa che può portare a una vera e propria "illuminazione".
È importante tenere presente che questa "illuminazione" arriva quando si è pronti per accoglierla, quando si possiedono gli strumenti per comprendere ciò che si vede.
On-line non è facile trovare video che ritraggono il Maestro in movimento. Un motivo è che nel rivedersi prova una sorta di "vergogna" (positiva) per i tanti difetti ed errori che individua nel proprio modo di muoversi.
Un atteggiamento che ricorda a ogni artista marziale quanto sia importante lavorare continuamente sul miglioramento di ogni singolo gesto. Anche quando si è un maestro.
In modo del tutto spontaneo l’intervista si è poi spostata sull’altra dimensione che il maestro vive ogni giorno: il buddismo zen. Il Maestro mi ha illustrato come le "due vie", le arti marziali e il buddismo, si sono incontrate nella sua vita fin dall’inizio. Sin da quando era adolescente (quando iniziò a praticare il Karate).
Si avvicinò a entrambi questi mondi attraverso le poche letture disponibili. Negli anni Settanta libri e riviste specializzate non abbondavano. La difficoltà era inoltre legata al fatto che non sempre i contenuti proposti erano di buona qualità. Fortunatamente, avendo una conoscenza discreta dell’inglese, poté ricorrere a libri e riviste straniere.
Fin dai primi anni della pratica ha percepito qualcosa di più profondo in una disciplina che apparentemente è solo fisica.
Il buddismo, così, diventò presto una chiave di lettura della pratica del Karate, che non rimase così un mero esercizio atletico, ma qualcosa di più profondo.
Cosa che non avviene per la gran parte delle persone che praticano, purtroppo. A suo avviso, il "non cogliere" che la pratica di un’arte marziale è più di un’attivitò legata al movimento fisico ha portato alla "deriva sportivo agonistica".
Per il Maestro lo studio di un’arte tradizionale è differente dallo sport agonistico. La scelta della federazione di puntare prevalentemente su quest’ultimo può, a suo avviso, portare a uno svilimento dell’arte stessa. Mi ha confidato che un suo sogno è che un giorno la disciplina possa uscire dall’ambito sportivo e che possa esistere un "settore" apposito per le arti tradizionali. Il suo sogno è che il Karate, come le altre arti marziali tradizionali, siano riconosciute come arti vere e proprie al pari della musica o della danza.
La competizione sportiva porta a focalizzare l’attenzione sulla prestazione fisica. Un anno può essere più di “moda” un gesto secco e l’anno dopo un gesto più veloce o più lento. Le gare sono come delle esibizioni, in cui però non emergono i fondamenti del movimento.
Nel suo dojo di Roma fa praticare quotidianamente un kata chiamato Sanchin (originario proprio della Cina), considerato il cuore di molti stili. Sanchin significa "tre battaglie". Non si riferisce a combattimenti reali, ma a una battaglia interiore che coinvolge corpo, mente e spirito. Basato sulla respirazione e la tensione muscolare, richiede uno studio sulla postura in modo che tutte le articolazioni del corpo diventino un’unità in ogni gesto ed è considerato una sorta di meditazione in movimento. Un lavoro differente da quello della "performance fisica da gara". Nella ricerca della prestazione da gara spesso manca quella qualità fondamentale di controllo del proprio centro e di quel movimento che nasce dalla conoscenza del proprio sé.
Anche per questo c’è un concreto impegno della federazione di cui fa parte di far riconoscere dall’UNESCO il Karate di Okinawa come patrimonio dell’umanità (come è già avvenuto per il Taiji Quan).
L’incontro più importante nella vita di un artista marziale e per un praticante Zen è con "il" maestro. "Il" maestro gli apparve quando incontrò il maestro Fausto Taiten Guareschi. Nel 1984 il maestro Guareschi ha fondato il tempio e monastero Fudenji sull’appennino parmense tra Fidenza e Salsomaggiore Terme, tutt’oggi un importante centro di spiritualità e cultura.
Il maestro Spongia nello stesso periodo in cui iniziò a praticare il Karate di Okinawa sotto la guida di Morio Higaonna Sensei inizià anche a frequentare il maestro Guareschi.
La guida del maestro Guareschi per il maestro Spongia è stata preziosa per comprendere come nel buddismo zen si apprende come utilizzare lo stato che la mente acquisisce durante lo zazen. In particolare, per lui, uno dei momenti migliori in cui cogliere l’intuizione che si ricerca con la meditazione è nello studio del movimento del corpo che compie durante la pratica del Karate. La pratica marziale a sua volta gli ha dato le chiavi per interpretare e comprendere più "rapidamente" la pratica dello zazen.
L’incontro con lo Zen ha dato al maestro Spongia molteplici chiavi di lettura e di comprensione di ciò che studia nell’ambito del Karate di Okinawa.
Nell’ascoltare le parole del maestro ho "rivisto" le medesime sensazioni e pensieri riguardo la mia pratica del 太極拳 tàijí quán, coniugata con lo studio della visione daoista del mondo.
Come ho raccontato nel mio libro "Una tamerice in attesa della sua primavera", nella pratica del Taiji Quan ho trovato uno strumento straordinario e prezioso per cercare la mia "via" verso il 道 dào. Uno strumento che desidero che i miei allievi e allieve possano cogliere anche sotto questo aspetto. Sono però consapevole che ciò che per me è uno strumento prezioso non è automatico che lo possa essere per chi studia con me. Sono consapevole che la gran parte delle persone che studiano nella scuola che ho fondato cercano solo un’attività motoria per stare bene. Devo saper dosare il mio desiderio di condividere qualcosa che ritengo prezioso con chi, magari, non ne sente la necessità. Posso solo confidare che un giorno l’illuminazione possa arrivare anche ai miei allievi e alle mie allieve. Come sottolinea il maestro Spongia, l’unico modo per riuscire in questo è l’esempio.
Il confronto con un maestro o una maestra può essere l’occasione di "comprendere" meglio il proprio percorso. Di vedere illuminato un dettaglio che improvvisamente assume un significato nuovo. Di comprendere come la pratica di un’arte marziale va oltre il piano fisico.
Se è vero che fin da subito le "due vie" furono presenti nella vita del maestro Spongia, è altrettanto vero che, se si sono influenzate a vicenda, non si sono mai mescolate nel suo insegnamento. Il Maestro mi ha spiegato come nella sua scuola non ha mai voluto "confonderle".
Con il tempo per lui le due vie si sono fuse spontaneamente. Di conseguenza fu normale sentire il desiderio di condividere lo zazen, un tesoro preziosissimo, con i propri allievi e le proprie allieve.
Il suo maestro lo consigliò di non mescolare le due cose, di tenerle distinte. Anche se inizialmente non comprese il consiglio lo seguì e con il tempo ne comprese l’importanza. Il pericolo insito nel presentare le due discipline unite è che si potrebbe percepire la meditazione, il rito dello zenkai, come un "esercizio" integrativo della pratica marziale (cosa che ovviamente non è).
Nel suo dojo fra bambini e adulti ha più di cento persone iscritte. Le persone che però praticano entrambe le "vie" sono una manciata, sette od otto. Il motivo è che sono poche le persone che comprendono appieno lo spirito della meditazione e la sua importanza.
È chiaro che le due attività sono svolte in giorni e orari differenti, creando delle "difficoltà" alle persone che vogliano partecipare a entrambe. Oggi, infatti, ritagliare del tempo da dedicare alla pratica nella propria quotidianità è sempre più difficile. Allo stesso tempo trovare nel medesimo luogo la possibilità di studiare sia un’arte marziale che il buddismo zen è un’opportunità che va in contro proprio alla "mancanza" di tempo.
Dopo queste riflessioni ho posto al maestro una domanda che a mia volta mi è stata spesso posta riguardo il daoismo e la mia pratica marziale: "la pratica di un’arte marziale non è in contraddizione con la visione del mondo del buddismo zen?"
Il Maestro mi ha risposto con un detto a lui caro: "Solo chi indossa la spada e non la sguaina può dirsi pacifico, chi non indossa la spada non saprà mai se è veramente pacifico."
Lo studio di un’arte marziale ci offre l’opportunità di conoscere il nostro sé, di conseguenza, ci permette di affrontare anche il nostro lato "non pacifico". Ci permette di affrontare le nostre paure. Aspetti che ogni persona possiede perché fanno parte della natura umana.
Le arti marziali permettono di acquisire quella solidità e quella conoscenza di sé che permettono di compiere una vera scelta consapevole verso una via di pace.
Del resto, il Buddha fu membro della stirpe degli Shakya, una comunità di guerrieri (kshatriya) che governò un piccolo regno situato nell’attuale Nepal, vicino a Kapilavastu. Fu addestrato a essere un guerriero e un condottiero.
Per questo non ha mai trovato una contraddizione fra lo studio dell’arte marziale e lo studio del buddismo zen. Anzi. Mi ha sottolineato come la visione di Jigoro Kano, il fondatore dello Judo, lo abbia sempre ispirato. Kano nell’elaborazione dello Judo enfatizzò l’importanza della forza, non solo in termini fisici ma anche mentali e morali, per essere utili nella vita.
Questo il maestro Paolo Taigo Spongia insegna nel suo dojo di Roma. Insegna che l’arte marziale deve formare delle persone oneste, sane e forti che possono scegliere la via della pace.
Il Maestro mi ha descritto come durante i corsi istruttori, che molti anni fa conduceva nella federazione italiana, spesso esordiva ricordando alle persone partecipanti che pochissime di loro avevano le qualità congenite necessarie per divenire un maestro o una maestra ma che con l’impegno potevano comunque diventare buoni istruttori. Il motivo, che condivido, è che insegnare non è per tutti. Insegnare richiede delle qualità innate, come l’empatia, l’intuizione, capacità psicologiche, che si affinano con l’esperienza.
Si può essere dei buoni istruttori ma la maestria è qualcosa di differente. Non è solo una questione di acquisire ed eseguire alla "perfezione" delle tecniche. Si può essere degli artisti straordinari, ma questo non significa che si è in grado di trasmettere la propria arte.
Si deve possedere un’infinita passione, un amore tale per l’arte che si studia, che si "deve" sentire il bisogno di condividerla. Anche perché, come ha sottolineato, il modo migliore per continuare a imparare a progredire è quello di trasmettere ciò che si studia. Man mano che gli allievi e le allieve crescono l’insegnante è stimolato a crescere. Non solo, mi ha colpito, quando mi ha spiegato come si impara a essere allievo vedendo il proprio maestro nel "ruolo" dell’allievo. Così si capisce come si interpreta il ruolo dell’allievo. Questo anche a costo di essere "ripresi" e "corretti" dai maestri davanti ai propri allievi.
Il Maestro mi ha illustrato questa metafora per farmi comprendere la sua visione della maestria. La maestria in un praticante di arti marziali tradizionali è paragonabile alla maestria di un portiere di calcio. Il portiere bravo non fa tuffi spettacolari. Si fa trovare sulla linea di tiro. Intuisce dove la palla andrà e si fa trovare là dove è necessario... certo è che un tuffo spettacolare è quello che fa applaudire il pubblico... ma non è lo spettacolo che ricerca una persona che pratica arti marziali.
Un maestro o una maestra di arti marziali non ricorre a gesti "plateali". Arriva prima che il gesto sia sviluppato.
Proprio riguardo all’insegnamento il Maestro mi ha raccontato di come non ci sia mai stato nei suoi piani il far divenire l’insegnamento il suo lavoro. Tutt’oggi si stupisce di come riesce a "vivere" grazie alle attività svolte nel suo dojo. Non ha mai contato il numero degli allievi. Se si trova in una classe un allievo o venti fa lezione allo stesso modo, con lo stesso interesse. Anzi, a volte, un piccolo numero di partecipanti è anche meglio sia per chi studia che per chi insegna.
Mi sottolinea questo aspetto perché quando si trova a formare delle persone che un giorno insegneranno ci tiene che queste comprendano che non devono mai percepire l’insegnamento come un "lavoro".
Non devono partire con lo spirito del "tirare su allievi" per sbarcare il lunario. Per il maestro Spongia, infatti, questo è un tarlo che con il tempo porta inevitabilmente a insegnare male, a ricercare il consenso degli allievi e delle allieve. Il rischio è dimenticare la missione dell'insegnamento.
Che il premio Pulitzer Henry Adams ha magnificamente sintetizzato nella sua autobiografia "The Education of Henry Adams": "A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops."
Metti in pratica la vera conoscenza
實踐真知
shíjiàn zhēnzhī
Francesco Russo
NOTE SULLA TRASCRIZIONE FONETICA
Le parole in lingua cinese quando appaiono per la prima volta sono riportate in cinese tradizionale con la traslitterazione fonetica. A partire dalla seconda volta, la parola è riportata con il solo pinyin senza indicazioni degli accenti per favorire una maggiore fluidità della lettura dei testi.
BREVE PROFILO DELL'AUTORE
Francesco Russo, consulente di marketing, è specializzato in consulenze in materia di "economia della distrazione".
Nato e cresciuto a Venezia oggi vive in Riviera del Brenta. Ha praticato per molti anni kick boxing raggiungendo il grado di "cintura blu". Dopo delle brevi esperienze nel mondo del karate e del gong fu, ha iniziato a praticare Taiji Quan (太極拳tàijí quán).
Dopo alcuni anni di studio dello stile Yang (楊式yáng shì) ha scelto di studiare lo stile Chen (陳式chén shì).
Oggi studia, pratica e insegna il Taiji Quan stile Chen (陳式太極拳Chén shì tàijí quán), il Qi Gong (氣功Qì gōng) e il DaoYin (導引dǎoyǐn) nella propria scuola di arti marziali tradizionali cinesi Drago Azzurro.
Per comprendere meglio l'arte marziale del Taiji Quan (太極拳tàijí quán) si è dedicato allo studio della lingua cinese (mandarino tradizionale) e dell'arte della calligrafia.
Nel 2021 decide di dare vita alla rivista Spiralis Mirabilis, una rivista dedicata al Taiji Quan (太極拳tàijí quán), al Qi Gong (氣功Qì gōng) e alle arti marziali cinesi in generale, che fosse totalmente indipendente da qualsiasi scuola di arti marziali, con lo scopo di dare vita ad uno strumento di divulgazione della cultura delle arti marziali cinesi.
Metti in pratica la vera conoscenza
實踐真知
shíjiàn zhēnzhī
Francesco Russo
NOTE SULLA TRASCRIZIONE FONETICA
Le parole in lingua cinese quando appaiono per la prima volta sono riportate in cinese tradizionale con la traslitterazione fonetica. A partire dalla seconda volta, la parola è riportata con il solo pinyin senza indicazioni degli accenti per favorire una maggiore fluidità della lettura dei testi.
BREVE PROFILO DELL'AUTORE
Francesco Russo, consulente di marketing, è specializzato in consulenze in materia di "economia della distrazione".
Nato e cresciuto a Venezia oggi vive in Riviera del Brenta. Ha praticato per molti anni kick boxing raggiungendo il grado di "cintura blu". Dopo delle brevi esperienze nel mondo del karate e del gong fu, ha iniziato a praticare Taiji Quan (太極拳tàijí quán).
Dopo alcuni anni di studio dello stile Yang (楊式yáng shì) ha scelto di studiare lo stile Chen (陳式chén shì).
Oggi studia, pratica e insegna il Taiji Quan stile Chen (陳式太極拳Chén shì tàijí quán), il Qi Gong (氣功Qì gōng) e il DaoYin (導引dǎoyǐn) nella propria scuola di arti marziali tradizionali cinesi Drago Azzurro.
Per comprendere meglio l'arte marziale del Taiji Quan (太極拳tàijí quán) si è dedicato allo studio della lingua cinese (mandarino tradizionale) e dell'arte della calligrafia.
Nel 2021 decide di dare vita alla rivista Spiralis Mirabilis, una rivista dedicata al Taiji Quan (太極拳tàijí quán), al Qi Gong (氣功Qì gōng) e alle arti marziali cinesi in generale, che fosse totalmente indipendente da qualsiasi scuola di arti marziali, con lo scopo di dare vita ad uno strumento di divulgazione della cultura delle arti marziali cinesi.
Acquista il libro dedicato al senso sulla pratica del Taiji Quan Una tamerice in attesa della sua primavera.
Scarica il nuovo numero di Spiralis Mirabilis, la rivista 100% gratuita dedicata al Taiji Quan ed al Qi Gong clicca qui.
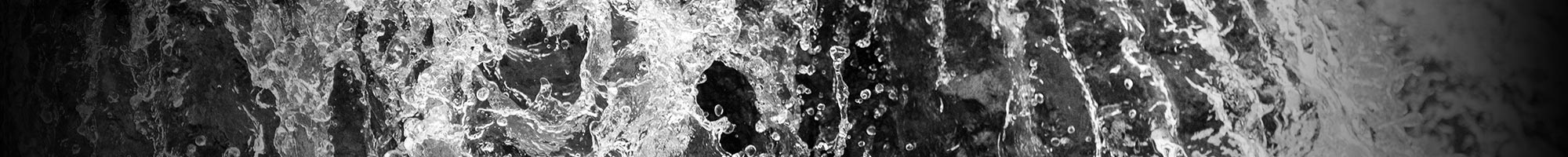
EVENTI
Viaggi
Seminari
Incontri sulla Via
Ⓒ2021 - | Progetto realizzato da BrioWeb C.F. e P.IVA 03853870271 | Informativa sulla privacy e sui cookie